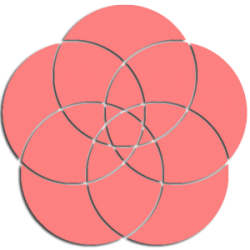Q: Buongiorno, Luca. Ho letto recentemente in una discussione che il ricorso alla sinestesia è possibile nella composizione di un haiku. È davvero così?
R: Com’è noto, la sinestesia (composto dai termini greci σύν, ‘insieme’, e αἴσθησις, ‘sensazione’ o ‘percezione’) è una particolare figura retorica che consiste nell’accostamento di parole appartenenti a differenti sfere sensoriali (ad esempio, “li verdi silenzii” di D’Annunzio(1)). Si tratta di un particolare tipo di metafora e il suo impiego, all’interno dello haiku, ha suscitato e pare suscitare tutt’ora dibattito negli ambienti letterari italiani.
Nello haiku “tradizionale”, effettivamente, le figure retoriche trovano poco spazio. In quanto artifici del discorso, infatti, esse contrastano con l’adozione di un linguaggio semplice, diretto ed immediato (si pensi, in particolare, all’iperbole, all’allegoria o alla stessa metafora), ed è preferibile lavorare sulla giustapposizione (toriawase 取り合わせ) tra immagini per produrre determinati effetti nell’animo del lettore.
Tuttavia, non è raro imbattersi, tanto nello haiku classico quanto in quello moderno e contemporaneo, in opere che impiegano questa peculiare forma espressiva. Un esempio è il seguente, notissimo, scritto di Matsuo Bashō (1644-1694):
海暮れて鴨の聲ほのかに白し
umi kurete kamo no koe honoka ni shiroshi(2)
si oscura il mare –
la voce delle anatre
d’un bianco indistinto
In questo caso, il candore del canto delle anatre è stato associato, dai diversi commentatori, ora alle bianche creste spumose del mare, ora invece al corpo degli uccelli, sino al bianco del respiro prodotto dagli stessi o dal poeta (l’opera è stata infatti composta in inverno)(3). Qualunque sia l’interpretazione data al testo, resta la peculiare attribuzione di una qualità visiva (il colore bianco) ad un elemento proprio della sfera uditiva (il canto delle anatre).
Ma gli esempi sono innumerevoli e non si limitano a quello sopra riportato. Ecco, infatti, una piccola rassegna di haiku in cui è ben presente la sinestesia:
早乙女やよごれぬ物はうたばかり
saotome ya yogorenu mono wa uta bakari(4)
piantatrici di riso –
non è infangato solo
il loro canto
Konishi Raizan (1653-1716)
鶯や黄色な声で親をよぶ
uguisu ya kiiro na koe de oya o yobu(5)
usignolo –
chiama i genitori
con voce gialla
Kobayashi Issa (1763-1828)
外にも出よ触るるばかりに春の月
to ni mo deyo fururu bakari ni haru no tsuki(6)
usciamo
solo per toccare
la luna di primavera
Nakamura Teijo (1900-1988)
Il mio suggerimento rivolto agli autori italiani è, come sempre, quello di non eccedere nell’utilizzo di questa figura retorica, ma di ricorrervi solo quando essa è in grado di attribuire una reale e genuina profondità all’opera e senza che la sua presenza appaia forzata e pretestuosa. Essa deve, cioè, armonizzarsi totalmente con l’atmosfera poetica complessiva, riverberandone ed amplificandone il portato con spontaneità e naturalezza, divenendo, nel caso della singola opera, l’unica scelta possibile in quel particolare contesto.
Note:
(1) Tratto dalla poesia Rosa dedicata ad Antonino Liberi, in G. D’Annunzio, Primo vere, Libro II, Carabba editore, 1879.
(2) I. Ōtsuka (a cura di), Bashō haiku zenshū, Naigai Shuppan Kyōkai, 1903, p. 196.
(3) In tal senso, P. Miller, Haiku Toolbox: Synesthesia, in Modern Haiku 44:3, autunno 2013, p. 45.
(4) T. Tsubōchi et al. (a cura di), Raizan hyaku ku, Izumi Shoin, 2005, p. 59.
(5) M. Horikiri (a cura di), Hyōgen to shite no haikai: Bashō, Buson, Issa, Perikansha, 1988, p. 327.
(6) T. Nakamura, Nakamura Teijo: Teijo jigazō, Nihon tosho sentā, 1997, p. 335.