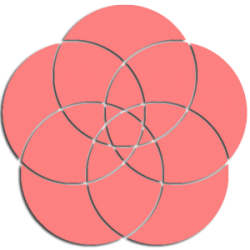Recensione del libro Sull’haiku di Yves Bonnefoy, O barra O edizioni, Milano, 2015, pp. 96, Euro 15,00.
La verità della legge cosmica e quella dell’istante umano possono qui legarsi, slegarsi, ricomporsi indefinitamente, in una circolarità che forse, nello spazio della parola, è ciò che più somiglia all’immediatezza alla quale non smettiamo di anelare.
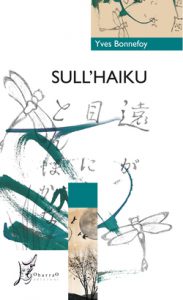 Sull’haiku di Yves Bonnefoy raccoglie quattro contributi dell’autore¹ – noto poeta e critico, recentemente scomparso – scritti in tempi diversi, ma accomunati dal desiderio di approfondire, con taglio lucido e, a tratti, filosofico, le problematiche relative alla traduzione e alla trasposizione di un genere poetico tanto peculiare (qual è, appunto, lo haiku giapponese) nel più ampio contesto culturale occidentale, in specie quello francese.
Sull’haiku di Yves Bonnefoy raccoglie quattro contributi dell’autore¹ – noto poeta e critico, recentemente scomparso – scritti in tempi diversi, ma accomunati dal desiderio di approfondire, con taglio lucido e, a tratti, filosofico, le problematiche relative alla traduzione e alla trasposizione di un genere poetico tanto peculiare (qual è, appunto, lo haiku giapponese) nel più ampio contesto culturale occidentale, in specie quello francese.
Così, nel primo contributo, intitolato proprio Sull’haiku, Bonnefoy rimanda al lettore gli elementi per una corretta comprensione dello haiku, ossia l’assenza di qualsivoglia pretesa descrittiva e di giudizio, in favore di uno slancio che predilige un’evocatività scenica volutamente ampia e indefinita, laddove «due aspetti del mondo, o due esseri, vengono accostati […] non tanto perché sono tra loro comparabili quanto, piuttosto, perché l’uno ha partecipato, in quell’istante e per simpatia, all’esistenza dell’altro», con ciò rimarcando la dote di unità che lega da sempre soggetto e oggetto, percipiente e percepito.
«L’haiku non formula ma, rapido, si fa slancio verso la cosa, fusione con essa, silenzio già all’interno delle sue parole», prosegue l’autore, evidenziando in più occasioni la distanza tra poesia giapponese e pensiero concettuale, quest’ultimo votato per sua stessa definizione alla classificazione degli eventi e ad un’appropriazione da parte di colui che produce tale pensiero.
La lingua giapponese (quella “pittura ideogrammatica” di cui parla Bonnefoy a più riprese) – forte di un legame “visivo” con l’oggetto rappresentato e, dunque, di un radicamento semantico di gran lunga più immediato – è un aspetto che l’autore non può ignorare, e che infatti pone immediatamente di fronte a lui il dilemma della traduzione, di una trasposizione nella propria lingua che inevitabilmente perde quel contatto primigenio con la realtà (“parole-cose”), favorendo all’opposto l’arbitrarietà di un linguaggio (quello occidentale) che sente essere un limite insormontabile.
Quel senso di vuoto, di cancellazione che, tuttavia, non significa ablazione indiscriminata ma riduzione all’essenziale (carattere decisivo dello haiku) porta peraltro Bonnefoy a riflettere, nel secondo intervento titolato Il fiore doppio, l’angusto sentiero: la nuvola, proprio sullo sviluppo stesso della poesia nipponica e sui suoi scopi; così, se da un lato, a suo vedere, i termini impiegati dai grandi maestri del passato (in specie, Matsuo Bashō) paiono non voler disvelare l’essenza delle cose rappresentate, quanto piuttosto ripristinare il legame intercorrente tra individuo e realtà circostante, dall’altro – riproponendo al lettore alcuni passaggi dell’Oku no hosomichi 奥の細道 (“Lo stretto sentiero per l’interno”) – lo haiku sembra proporre un momento di distacco (rizoku 俚俗) che cela costantemente in sé il rischio di uno scollamento con la realtà stessa, con il proprio vissuto, formalizzando così «un bivio, una prova» alla quale tutti noi siamo chiamati.
Ma il nucleo centrale della riflessione (sviluppato in particolare negli ultimi due interventi), come anticipato, è legato al problema della traduzione, del passaggio da una scrittura caratterizzata da segni «che spesso conservano nella loro forma parte dell’aspetto delle cose» a una scrittura che, al contrario, «abolisce il rapporto immediato col mondo»², favorendo piuttosto la concettualizzazione degli eventi e la loro ricostruzione secondo uno schema causale che inevitabilmente allenta i legami con il subitaneo, retaggio di uno sviluppo storico incentrato sul pensiero filosofico e teologico. Retaggio che, oltretutto, porta quasi fisiologicamente ad un’espansione di pensiero che fa della brevità espressiva un “incidente”, una casualità, specie in Francia; fanno eccezione solo alcuni passaggi delle Illuminations di Arthur Rimbaud (1854-1891) e, più in generale, le poesie composte intorno al 1872, segno, secondo l’autore, di un’approssimazione allo stile giapponese che, tuttavia, non riesce mai ad aderirvi perfettamente. «Il poeta francese ha una forte coscienza di sé in quanto persona», rincara Bonnefoy, con ciò lasciando trasparire un ulteriore elemento di distanza tra pensiero occidentale e orientale; il primo rivolto all’individuo in sé, centro inevitabile di ogni accadimento, il secondo, invece, caratterizzato dall’idea che «non ci sia nulla dietro ai fenomeni, che l’essere umano non debba considerarsi superiore alla natura».
Nell’ultima sezione del libro (intitolata Si può tradurre un haiku?) l’autore presenta dunque al lettore le proprie considerazioni finali. Posto che, nella lingua giapponese, «la parola e la cosa sono tutt’uno» e che, a differenza del poeta occidentale, la composizione di uno haiku è in sé un’esperienza unica ed irripetibile anche per il modo stesso attraverso cui quest’ultimo vede la luce – con la mano del calligrafo che dà vita a quei segni-parola che, come detto, riproducono senza convenzioni o simbolismi la realtà – è per noi certamente possibile avvicinarci alla poetica dei grandi maestri, ma non senza perdere il gesto che ne è manifestazione naturale, né senza mutilare quella musicalità e quella semantica che, nella lingua originale, sono garantite da una serie di elementi stilistici e concettuali irriproducibili in maniera fedele, quali ad esempio i kireji 切れ字.
Bonnefoy propone, a tal fine, una “salvaguardia” dello spirito poetico durante il processo traspositivo da una lingua all’altra tramite ricorso ai commentari, ossia a quelle note integrative al testo che permettono al lettore di cogliere aspetti che, altrimenti, andrebbero irrimediabilmente perduti, in ossequio alle unicità di una lingua la cui parola «si fa designazione diretta, constatando la cosa senza tentare di analizzarla, ma amando vederla vicina a un’altra o ad altre due, poiché il mondo non si presenta al poeta se non come una totalità le cui simultaneità sono l’evocazione più naturale».
In conclusione Sull’haiku, summa di pensiero di una delle voci più significative della poesia europea del Novecento, sebbene guidi il lettore attraverso una serie di riflessioni ab origine orientate verso determinati esiti, lascia allo stesso tempo ampi margini di gioco, rivolgendo al proprio interlocutore interrogativi ai quali non ha mai la pretesa di fornire una risposta univoca; si muove tra gli interstizi di un’indagine letteraria e, per certi versi, filologica ben conscio dei propri limiti interpretativi («ciò che avverto nelle grandi parole fondamentali delle nostre lingue [è che] forse non capisco del tutto l’haiku»), rimandando a chi avrà la pazienza di leggere il compito di sciogliere con le proprie mani i nodi di una questione che, forse, resterà sempre insolubilmente aperta, nella consapevolezza che «la poesia non è la rinuncia mistica a tutti gli aspetti del mondo e dell’esistenza, ma un modo di viverne alcuni, scelti per la loro verità».
Note
¹ Du haïku (Mercure de France, 1990), La fleur double, la sente étroite: la nuée (Mercure de France, 1977), Le haïku, la forme brève et les poètes français (Éditions du Seuil, 2013) e Peut-on traduire le haïku? (Éditions du Seuil, 2013).
² Come evidenzia lo stesso Bonnefoy, infatti, «il segno verbale è fondamentalmente arbitrario. La parola “cane” non evoca nulla dell’aspetto fisico del cane [e] pressoché nessun vocabolo somiglia al proprio referente».