Recensione della raccolta Karumi. Haiku & Tanka di Fabrizio Frosini, Amazon Media EU S.à r.l., 2015, Euro 2,99 (versione e-book).
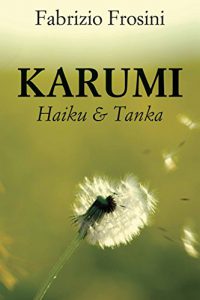 Karumi. Haiku & Tanka di Fabrizio Frosini è un’opera composita, che si distingue dalle altre sia per il considerevole numero di componimenti presenti (246 tra haiku, senryū e tanka), sia per gli interessanti approfondimenti che aprono il lavoro. In particolare, nella nota introduttiva La poesia giapponese a cura dello stesso autore, questi propone al lettore un excursus storico sulle principali forme poetiche giapponesi dal VI secolo ai giorni nostri, unitamente ad una sintetica ma esaustiva disamina dei caratteri – sia formali che sostanziali – di haiku, senryū e tanka.
Karumi. Haiku & Tanka di Fabrizio Frosini è un’opera composita, che si distingue dalle altre sia per il considerevole numero di componimenti presenti (246 tra haiku, senryū e tanka), sia per gli interessanti approfondimenti che aprono il lavoro. In particolare, nella nota introduttiva La poesia giapponese a cura dello stesso autore, questi propone al lettore un excursus storico sulle principali forme poetiche giapponesi dal VI secolo ai giorni nostri, unitamente ad una sintetica ma esaustiva disamina dei caratteri – sia formali che sostanziali – di haiku, senryū e tanka.
Estremamente apprezzabile come, in controtendenza rispetto alla maggior parte degli pseudo-esperti di poesia giapponese che popolano, in particolar modo, i social network italiani, il Frosini dimostri di aver compreso la natura e gli scopi del genere senryū 川柳, che non è un mero haiku privo di kigo 季語, ma un genere completamente diverso, con una propria dignità letteraria e caratterizzato da una sagace penetrazione nell’animo umano, talvolta ironica e talaltra profondamente sentimentale e, a tratti, commovente. Leggi tutto “Il ramo del susino”

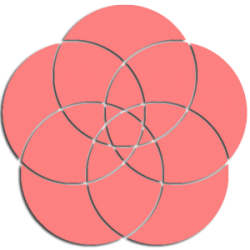
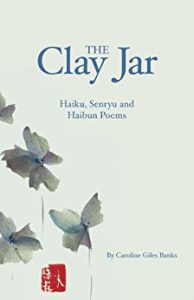 The Clay Jar è una raccolta di haiku, senryū e haibun pubblicata nel 2013 dalla poetessa americana Caroline Giles Bank (attiva nel panorama letterario internazionale sin dalla fine degli anni Ottanta), uscita quasi in contemporanea alla forse più nota opera Tigers, Temples and Marigolds, edita nello stesso anno sempre per i tipi della Wellington-Giles Press.
The Clay Jar è una raccolta di haiku, senryū e haibun pubblicata nel 2013 dalla poetessa americana Caroline Giles Bank (attiva nel panorama letterario internazionale sin dalla fine degli anni Ottanta), uscita quasi in contemporanea alla forse più nota opera Tigers, Temples and Marigolds, edita nello stesso anno sempre per i tipi della Wellington-Giles Press.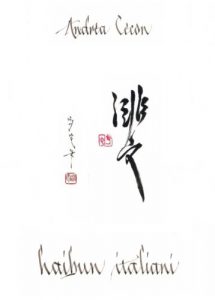 «Lasciata la mia dimora, non desidero nulla. Avendo le mani vuote, non temo le insidie del viaggio.» Matsuo Bashō (dall’Oi no kobumi 笈の小文)
«Lasciata la mia dimora, non desidero nulla. Avendo le mani vuote, non temo le insidie del viaggio.» Matsuo Bashō (dall’Oi no kobumi 笈の小文)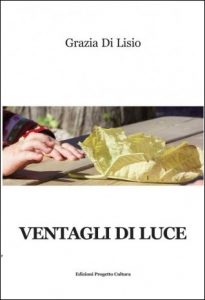 Leggendo questa raccolta di Grazia Di Lisio non si può fare a meno di restare colpiti, in prima istanza, dalla leggerezza (karumi 軽み) e dalla delicatezza (shiori しをり) che pervadono ogni componimento. Così, mentre la prima direttrice apre a un’estetica fondamentalmente votata all’esaltazione della spontaneità poetica in simbiosi con il dato naturalistico — e, dunque, in netto contrasto con un’elaborazione statica (omomi 重み) e priva di reale slancio — la seconda condivide con il lettore un’ineludibile verità: l’incessante scorrere del tempo e l’impotenza dell’uomo nei suoi confronti, con il conseguente avvizzimento di ciò che prima era nel pieno del proprio vigore. Ne è testimonianza la stessa strutturazione dell’opera, divisa in sei sezioni, nella quale il nucleo centrale è rappresentato dai mutamenti stagionali, in un’ottica che comunque resta sempre “aperta”, ricettiva e decisamente non preconcetta. Facendo propria quella capacità di lasciarsi “attraversare” dalle cose del mondo (mono no aware 物の哀れ), infatti, la Di Lisio traccia un cerchio discreto ma deciso sulle sabbie della tradizione haikai, mutuando da questa uno sguardo sottile (hosomi 細身) e attento a ogni più piccolo accadimento, facendolo proprio nella misura in cui questo serva a cancellare ogni distanza tra percipiente e percepito e lasciandolo, infine, andare, proprio come uno specchio che non trattiene nulla di ciò che riflette:
Leggendo questa raccolta di Grazia Di Lisio non si può fare a meno di restare colpiti, in prima istanza, dalla leggerezza (karumi 軽み) e dalla delicatezza (shiori しをり) che pervadono ogni componimento. Così, mentre la prima direttrice apre a un’estetica fondamentalmente votata all’esaltazione della spontaneità poetica in simbiosi con il dato naturalistico — e, dunque, in netto contrasto con un’elaborazione statica (omomi 重み) e priva di reale slancio — la seconda condivide con il lettore un’ineludibile verità: l’incessante scorrere del tempo e l’impotenza dell’uomo nei suoi confronti, con il conseguente avvizzimento di ciò che prima era nel pieno del proprio vigore. Ne è testimonianza la stessa strutturazione dell’opera, divisa in sei sezioni, nella quale il nucleo centrale è rappresentato dai mutamenti stagionali, in un’ottica che comunque resta sempre “aperta”, ricettiva e decisamente non preconcetta. Facendo propria quella capacità di lasciarsi “attraversare” dalle cose del mondo (mono no aware 物の哀れ), infatti, la Di Lisio traccia un cerchio discreto ma deciso sulle sabbie della tradizione haikai, mutuando da questa uno sguardo sottile (hosomi 細身) e attento a ogni più piccolo accadimento, facendolo proprio nella misura in cui questo serva a cancellare ogni distanza tra percipiente e percepito e lasciandolo, infine, andare, proprio come uno specchio che non trattiene nulla di ciò che riflette: